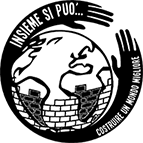Due di loro
di Francesco De Bon
D. e J. sono Nigeriani, entrambi profughi dalla Libia, sbarcati a Lampedusa e arrivati a Santo Stefano di Cadore (BL) nel maggio 2011, insieme ad altri 90 ragazzi e in seguito ospitati in un alloggio presso il campo volo di Belluno e accuditi da una famiglia locale.
Hanno raccontato le loro storie agli studenti dell’Istituto Catullo di Belluno nell’ambito di un progetto sulla tratta delle persone condotto da “Insieme si può…” e Libera. J. non aveva mai parlato in pubblico della sua storia.
Abbiamo cercato di raccogliere lo spirito delle loro parole, pur con la difficoltà di rendere le emozioni in una lingua diversa dalla loro; in ogni caso non togliendo o aggiungendo nulla ai fatti così come raccontati.
Come D. e J. potrebbero raccontare la loro storia le altre 293.000 persone che in dieci anni hanno attraversato il canale di Sicilia. Non conosceremo nulla, invece, dei 7.000 uomini, donne e bambini che in quel cimitero fatto d’acqua hanno perso la vita; 5.000 di loro non sono mai stati ritrovati.
D.
Sono scappato con tutta la mia famiglia dalla miseria del mio paese, la Nigeria, verso la speranza di una vita migliore in Libia. Con fatica una casa, un lavoro modesto, poche cose sufficienti per vivere, un pò di campo da coltivare. Una vita povera, ma finalmente dignitosa.
Poi un giorno scoppia la rivolta. Inizialmente non ce ne siamo neppure accorti perché il nostro paesino era distante dalle grandi città. Di tanto in tanto, voci che parlavano di bombe, guerriglia, morti, attacchi aerei da parte di nonsisachi, addirittura di rastrellamenti dell’esercito a caccia di uomini da reclutare per Gheddafi. Si diceva che chi si rifiutava venisse giustiziato. Si diceva.
La realtà è arrivata di colpo come un tuono. Anzi come un rumore sordo, soffocato, come una specie di vento caldo e immobile. Più mi avvicinavo a casa più diventava insopportabile. Tornavo da una passeggiata.
Se nessuno sa com’è l’inferno… io credo in quel momento di averlo visto. I polmoni strozzati, gli occhi rossi di fumo e di pianto, le mani bruciate a scavare la disperazione, il puzzo di cenere e di carne bruciata. Ho perso la nonna, la mamma, il papà e due fratelli, tutti arsi vivi con la nostra casa. Non sono voluti andare a combattere.
La seconda parte della mia vita inizia la mattina dopo, dalla panchina in un parco, casa mia per una notte. Mi dicono di alzarmi e andare via, è pericoloso, tornano i soldati.
Scappo di nuovo, questa volta su un barcone verso Lampedusa. Questa volta solo.
J.
Nostra madre non ha mai accettato la religione di mio padre: spiriti, demoni, feticci, animali, sacrifici… Credeva che la strada da seguire fosse quella percorsa da Gesù e ce l’ha sempre indicata chiaramente. Ma io e mio fratello maggiore, fin da piccoli, dovevamo leggere il vangelo di nascosto, di sera o quando nostro padre non era in casa: la mamma su questo era severissima e tradiva paura.
D’altra parte papà era il capo del nostro paese, la legge e la religione erano le sue: lo chiamavano re. E mio fratello maggiore, principe. Vivevamo in una villa lussuosa costruita nella miseria tutta intorno e avevamo molto di più di quello che ci serviva. Parlarne ora, qui in Italia, m’imbarazza, mi dicono che sembra il medioevo: difficile credere che in molti paesi nigeriani è proprio così.
Nostro padre morì all’improvviso; mio fratello, il primogenito, sarebbe diventato il nuovo re e avrebbe dovuto ereditare ogni cosa, prima di tutto la religione. Per questo motivo si rifiutò.
La disperazione di nostra madre, le sue implorazioni, il suo offrirsi in sacrificio per il figlio non bastarono. Mentre lo trasportarono nella foresta, intontito dai fumi e dalle erbe, ci salutava con occhi ormai spenti. Lo sacrificarono ancora vivo e lo lasciarono tra gli alberi, così gli spiriti si sarebbero calmati.
Mia madre mi mise in mano un vangelo e del denaro e, il viso deformato dal dolore, mi ordinò di scappare. Io, secondogenito, sarei venuto dopo di lui.
Più di 4000 chilometri fino a Tripoli attraverso il Sahara. Un caldo che non avrei mai immaginato potesse esistere, pressati in un container come animali, mezza bottiglia d’acqua al giorno per bere e rinfrescarsi, le piaghe per il sudore e per le botte ricevute.
Poi, gli occhi fissi verso la fine del mare, mi sono chiesto per giorni se davvero Gesù potesse aver sofferto più di me.