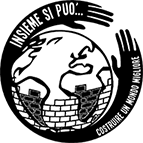Afghanistan 2013. Un’impressione.
Di Daniele Giaffredo.
Uno tra i ricordi più vivi che conservo delle parole del nostro presidente Mario Fontana è un frammento di conversazione tra me e lui, un pomeriggio in ufficio, nel 2008.
Era autunno, Mario era di ritorno da un viaggio in Afghanistan: “Quello che vedi laggiù è terribile”, mi disse.
E poi, con lo sguardo vago e basso, come a cercare egli stesso un appiglio: “E’ un popolo che non ha futuro, la gente che non ha più la speranza”.
Diverse volte mi è capitato di riflettere su quelle parole e di citarle. La condizione umana più disperata mai incontrata da Mario, che certo di Paesi del Sud del mondo ne aveva girati tanti, era dunque l’Afghanistan. Uno si immaginerebbe al primo posto, in questa classifica al contrario, la miseria delle favelas nel Sud America, o l’estrema povertà di alcune regioni dell’Africa Sub sahariana. Invece no, era l’Afghanistan che si era stampato come l’esperienza più sconvolgente di tutta una vita. La moglie Giusi, che con gli amici Carla e Olindo aveva preso parte a quel viaggio, mi aveva confessato che Mario era un giorno arrivato alle lacrime, toccato nel profondo dell’animo.
Quale l’elemento distintivo, dunque, che fa di questa terra la terra più disgraziata? Che in Afghanistan non c’è speranza. Perché la miseria più maledetta, le privazioni più inumane possono essere vissute da un popolo quasi con trascuratezza, se si proietta la propria esistenza oltre il buio perché già si distinguono i segni buoni di un domani migliore. Ma se non hai la speranza, se ogni giorno ti svegli con la certezza di veder soffrire i tuoi figli e la tua gente, se la tua vita è minacciata da ogni dove e chi dovrebbe proteggerti difende invece i tuoi aggressori… A quel punto puoi e vuoi solo scappare dalla tua terra.
O dalla tua stessa vita.
Marzo 2013. In questo viaggio, appena concluso, in Afghanistan ho accompagnato la nostra volontaria Carla Dazzi che da diversi anni, instancabilmente, si reca in visita alle organizzazioni e ai progetti sostenuti da “Insieme si può…” in difesa dei diritti degli indifesi.
Sono le vite straziate delle donne afghane, private della dignità in ogni ambito sociale e famigliare, a fluire e sedimentare in maniera dolcissima e violenta allo stesso tempo. Dedico il primo pensiero alle bambine che diventano mogli già a dodici anni, per ripagare i debiti della famiglia d’origine o come merci di scambio per risolverne le controversie. Ma subito si ripresentano nitidi gli innumerevoli casi di ragazze rapite e violentate che, rientrando disperate in famiglia, vengono uccise perché quella stessa violenza da loro subita ne disonora il buon nome. Sono oltre duemila ogni anno, più di sei al giorno, quelle che arrivano ad una disperazione così nera da scegliere di auto immolarsi cospargendosi il corpo di benzina e dandosi fuoco, nel tentativo di togliersi la vita.
Tutto questo orrore nonostante una legge, in vigore dal 2009, che sanziona i matrimoni forzati e gli atti di violenza civile e familiare contro le donne, e che promulga la parità del diritto all’istruzione. Una legge raramente applicata, da giudici che rimangono in molti casi misogini, in molte aree disattesa perché nessuno si preoccupa di sradicare norme e punizioni arcaiche e tradizionali. Il fatto è che persiste un radicato sentire fondamentalista, ben rappresentato ai massimi vertici di un governo affollato dai soliti arricchiti signori della guerra, funzionali al “controllo” delle varie componenti etniche e tribali. Ma non solo: è un sentire radicato anche nella forza pubblica e purtroppo anche nell’apparato giudiziario. E’ un sentire che ribadisce il concetto di donna non quale soggetto, ma quale oggetto, da reprimere senza esclusione di colpi.
A rileggere queste stesse mie parole, rischio di rimanere pure io sbigottito: in Afghanistan – così mi è stato per anni riportato dagli autorevoli media nazionali e internazionali – le pratiche fondamentaliste e violente verso donne e bambine sono un brutto ricordo degli anni ’80 e ’90, del periodo dei mujaheddin e dei talebani. E ora posso invece solo avvilirmi, pensando a quanto questa versione della realtà sappia di beffa: una specie di cortina di vetro opaco ci impedisce tuttora di fare luce, con onestà, sui risultati di un impegno che ha coinvolto mezzo mondo – noi italiani tra i primi – nel portare sino laggiù la pace e i diritti.
Quando si cerca di raccontare che l’Afghanistan è tra le nazioni più povere della terra, secondo molti indicatori la più povera in assoluto, essere creduti è quasi impossibile. Questo perché è difficile accettare l’idea di essersi illusi, di aver speso tanto per nulla. E allora, nella loro aridità, si possono portare degli esempi con le cifre. Gli Stati Uniti, da soli, spendono per la loro missione militare circa 1 miliardo di dollari a settimana.
Ogni settimana, al contempo, 60 milioni di dollari dovrebbero essere impiegati per progetti a beneficio della collettività, per la ricostruzione sociale ed economica, per la promozione e affermazione della giustizia e dei diritti fondamentali come la salute, la scuola, l’acqua, il cibo e la tanto sbandierata “gender equality – women empowerment” (Parità di genere – consolidamento del ruolo della donna). Ma lo stesso ministero dell’economia afghano, e così le agenzie delle Nazioni Unite, riportano che la crescita economica è a zero, e che circa l’80% degli aiuti internazionali – senza contare corruzioni e collusioni varie – finisce in realtà a beneficio degli stessi donatori.
Lo specchio di tutto questo è la situazione odierna di questo stato, che a troppi – occidentali e non – risulta più conveniente e funzionale lasciare nell’abbandono socio economico e nel caos. 6 milioni di persone (su 35 in totale) sono disoccupate e sono 6 milioni anche i bambini che vivono per strada. In Afghanistan si muore di freddo, di fame, di malattie che sarebbe banale curare o prevenire. Ogni 2 ore una donna muore di parto. Sul piano dell’istruzione femminile, per concludere la panoramica nella quale ci siamo impelagati, i dati sono agghiaccianti. Solo 1 donna su 4 sa leggere e scrivere. 2000 bambine e ragazzine, l’anno scorso, sono state aggredite o hanno subito violenza nel tragitto verso la scuola o addirittura a scuola.
Purtroppo la situazione risulta bloccata, congelata, come documentano le voci libere e democratiche in parlamento (il partito di Hambastagi, Belquees Roshan, e ovviamente Malalai Joya, violentemente cacciata dall’assemblea proprio per il suo coraggio di denuncia) e le associazioni per la promozione e la tutela dei diritti umani per donne e bambini (come OPAWC, HAWCA, RAWA, organizzazioni che “Insieme si può…” sostiene da tempo).
La soluzione che tutti questi soggetti indicano come unica via si articola in tre punti semplici quanto indiscutibili. L’estromissione dei signori della guerra dai ruoli di potere, politico ed economico (e della droga). L’abbandono delle forze militari di occupazione che stanno di fatto perpetrando uno status quo paradossale rispetto ai declamati intenti. La promozione e l’attuazione concreta dei diritti delle donne, anche attraverso una generale ristrutturazione del sistema giudiziario e scolastico. Solo a queste conduzioni, la gente dell’Afghanistan potrà cominciare a ricostruire il proprio futuro.
Il nostro impegno, nel frattempo, non si ferma. I progetti che abbiamo avviato con le ONG locali sono la forza e l’incoraggiamento per quanti si sentirebbero altrimenti dimenticati e abbandonati dal mondo intero.
“Insieme si può…” sostiene:
- OPAWC, un’organizzazione che promuove l’impiego e il ruolo sociale delle donne, attraverso l’alfabetizzazione, la formazione scolastica e professionale, l’inserimento nel mondo del lavoro
- HAWCA, un’organizzazione che offre protezione e assistenza alle vittime di violenza e ai profughi di guerra, promuove attività di microcredito e di sostentamento a favore delle donne, offre assistenza sanitaria e legale
- AFCECO, una rete di orfanotrofi che ospita quanti sono rimasti privi di famiglia, in molti casi proprio a causa della guerra, a Kabul come in altre province dell’Afghanistan.
Infine, merita qualche riga quel progetto “targato” ISP che è il Microcredito delle capre: ne beneficiano le donne afghane vedove o vittime di emarginazione economica e sociale, cui viene affidata una capra per il sostentamento loro e dei loro bambini (è un progetto che fa parte dei Regali senza frontiere di ISP). In una situazione di clandestinità e tensione, con qualche rischio in termini di sicurezza, abbiamo avuto l’emozione di incontrare un gruppo di donne beneficiarie della provincia di Parwan alle quali – formalmente e materialmente! – abbiamo consegnato 17 capre.
In quegli istanti, vorresti saper spiegare a quei volti increduli e riconoscenti che cosa è “Insieme si può…”, vorresti avere il tempo di far capire che con noi, a consegnare quelle capre, ci sono in quel momento centinaia di donne, uomini e bambini, che sono distanti migliaia di chilometri ma stanno dalla loro parte, non si arrendono ad una parte di umanità che vive nella disperazione. Vorresti spiegare ma non c’è tempo e non c’è modo.
Grazie a Dio, nei rapidi abbracci – prima di risalire di corsa nei furgoncini che riporteranno noi nel nostro shelter a Kabul e le donne, riavvolte nei loro burka, ai loro villaggi con le nuove caprette – è racchiusa ogni cosa. C’è anche tutto l’animo di quel presidente di cui si diceva all’inizio. Quel Natale di rientro dall’Afghanistan, a quelle donne, a quella “gente che non ha più la speranza” – crucciato, disilluso, testardo e sognatore come tutti noi – , Mario, col sorriso, di capre ne aveva donate sei.