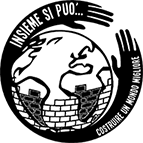#salute: Dourados, Brasile
Storie dell’altro mondo
Parlare di salute nella riserva indigena di Dourados è una questione complessa, molto complessa. Parto con il dire che io penso che gli indigeni abbiano una marcia in più: non so quanti di noi, vivendo in quelle condizioni malsane e disperate, nella sporcizia, senz’acqua e senza tutte quelle comodità che noi abbiamo, sopravvivrebbero. Vedo i bambini, con il freddo o la pioggia, che mi vengono incontro seminudi per chiedere il pane, con quelle mani sporche di fango e di chissà cosa, e poi lo mangiano e non prendono mai niente, neanche un raffreddore. A volte, per la fame, masticano pezzi di sacchetti di plastica, ma non si ammalano. Io ho lavorato con i bambini in Italia, e lì per delle piccole cose prendevano la febbre e stavano subito a casa.
L’indice di mortalità infantile nella riserva è calato molto, adesso sono 14 bambini su 1000 che muoiono per il parto o le sue conseguenze, e muoiono soprattutto per polmonite, dovuta però alle mamme, che non li portano dal medico o li portano troppo tardi. Ci dicono che da quando siamo arrivate noi qui nella riserva i bambini muoiono di meno, perché portiamo cibo ogni giorno e cerchiamo di curare l’alimentazione, che è la base per una buona salute.
Qui il sistema sanitario sembra buono sulla carta, ci sono 4 ambulatori e l’ospedale Kaiowã, che dovrebbe seguire solo gli indigeni con un medico a disposizione tutto il giorno e personale infermieristico. Ma la realtà è un’altra. Il primo problema sono le distanze: quasi nessuno ha la macchina, quindi se una persona si ammala in casa non ci sono ambulanze che arrivano. Ad esempio, la settimana scorsa abbiamo visto il caso di Ana Clara, che da giorni stava male, aveva febbre alta, vomito, chiari segni di denutrizione e di disidratazione. Hanno chiamato l’ambulanza del SESAI (una parte del Ministero della Salute dedicata specificatamente agli indigeni) e nessuno è andato a prenderla, poi mi hanno contattato e sono riuscita a farla portare qui da noi e da qui all’ospedale, dove è stata ricoverata 20 giorni.
Se qualcuno sta male in casa e chiama l’ospedale, spesso ci sono problemi: dicono che hanno tanta gente, che non c’è benzina per le macchine e non interviene nessuno. Per cui tante volte li portano qui, noi con insistenza riusciamo ad ottenere qualche risultato in più. Con Robson ad esempio: era a casa da una settimana con la febbre alta, abbiamo chiamato l’ambulanza e, quando hanno risposto dopo vari tentativi, hanno detto che non sapevano dove era il posto e che non avevano benzina. Io gli ho detto che li avrei aspettati sulla strada principale e li avrei accompagnati dal bambino, che si sbrigassero. In questo caso sono venuti, ma quanta fatica!
Poi in teoria l’organizzazione è buona: dicono che ci sono diversi numeri da chiamare, per la salute, per le vittime di violenze, poi quando c’è bisogno e provi a chiamare non risponde nessuno. Il secondo problema è questo: le persone comuni non ricevono attenzione, per quello vengono qui da noi, perché sanno che se chiamiamo noi non possono inventare scuse e se serve parliamo anche con i responsabili.
Un altro problema enorme sono i tempi di attesa. Prendiamo il papà di Charlie, il bambino malato di aplasia cerebrale che seguiamo con il Sostegno a Distanza. Sono due anni che aspetta un’operazione al femore, non cammina, ha perso il lavoro, si muove a fatica con le stampelle che gli abbiamo dato, ma resta in lista d’attesa. Anche un’altra mamma con i calcoli alla vescica sta soffrendo da tempo, ma nessuno la chiama.
Il sistema sanitario potrebbe funzionare, ma la realtà è che non va così se non conosci qualcuno o ti imponi con autorità. E comunque, anche se sono gravi, gli ultimi ad essere curati sono sempre gli indios.
di suor Aurora Cossu, Referente progetto SAD a Dourados (Brasile)